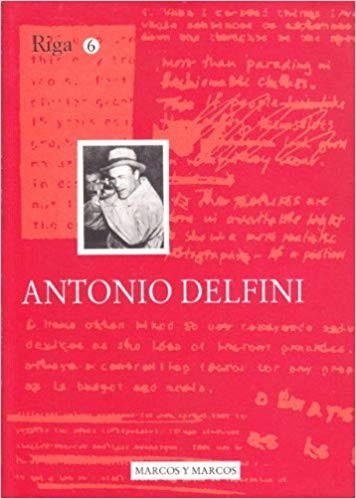Luigi Grazioli
Non voglio essere qui
Non voglio essere qui
Il becchino se la prende comoda. È un uomo allegro e paradossale che per stupire i visitatori, se sta facendo uno spuntino, non disdegna di catturare qualche insetto di stagione e di alloggiarlo tra la pancetta e il panino, che poi morde e mastica con gusto spropositato, condendo con amenità cloacali l’esibizione, gratuita peraltro. In privato pare che sia peggio: si sforza di fare il buon padre di famiglia. Infatti i suoi figli, per far dimenticare di chi lo sono, sono tutti i primi della classe. Adesso, mentre lavora col suo assistente, un succubo giulivo raccattato dalla pubblica amministrazione nel parentado di qualche consigliere comunale, fatica a reprimere una canzonetta i cui resti affiorano di tanto in tanto alle sue labbra contornate di sudore. Poco discosto l’ufficiale sanitario discute dell’ennesima figuraccia della nazionale di basket col maresciallo dei carabinieri, che continua a togliersi e a rimettersi il cappello sotto il sole, mattutino sì, ma di luglio. Inutile dire che non capiscono un’acca. Per questo, e perché non possono alzare la voce e azzuffarsi, infarciscono le loro scempiaggini di termini tecnici in ragione inversa all’effettiva comprensione: è l’ultima risorsa dei cretini. Di quelli educati, beninteso.
Qua e là i rari visitatori (il solito gruppetto di vedove che, eleganti, splendenti di una seconda, ben più felice giovinezza, si danno appuntamento al cimitero, a due a due o a tre a tre, per poi chiudere la mattinata in qualche bar; un ragazzo che smette di piangere non appena ci vede; due gemelli adulti che stanno portando dei fiori appassiti all’angolo della spazzatura) ci squadrano da lontano, indecisi se far prevalere la curiosità o la discrezione. L’oggetto della curiosità sono io, che vivo in città da più di vent’anni e, pur tornando spesso a casa di mia madre, non mi faccio vedere molto in giro. Forse qualcuno mi riconosce, o deduce chi io sia dalla tomba davanti a cui mi trovo.
Io non voglio essere qui. Mi hanno detto che la mia presenza era necessaria, che almeno un famigliare doveva assistere all’esumazione, e dietro le insistenze adeguatamente spruzzate di lacrime e preghiere di mia madre e mia sorella, che adoro, preferibilmente da lontano, sono venuto io; ma non volevo venire, e adesso che sono qui, ancora non voglio. Mia madre e mia sorella sovrintendono alla tomba chiusa, io all’apertura; loro alla normalità, al rito attossicato dal vizio pressoché quotidiano di mezzo secolo ormai, io all’effrazione. Così è stabilito, e io mi adeguo come meglio posso, costante nell’incostanza, schiacciato dalla leggerezza dell’assenza di vincoli evidenti che ha finito per appesantire anche i miei lineamenti una volta belli e questo corpo, che porto in giro come un pacco postale lasciatomi in deposito da qualcuno che poi non si è fatto più vedere, un povero corpo che non ha mai danzato.
Mentre becchino e aiutante si godono un po’ di fresco nella tomba della mia famiglia prima di estrarre la cassa dal suo alloggiamento e di metterla su due cavalletti previamente calati fino al pavimento, penso alla donna che avrei dovuto incontrare questa sera se non avessi rinviato l’appuntamento, e penso anche che avrei potuto rispettarlo, se avessi voluto, tanto le pratiche non dureranno a lungo; ma adesso non vorrei essere nemmeno con lei. Non voglio essere da nessuna parte. Mi sento, come mi capita spesso, ma con più forza, quasi che tutto (tutto cosa?) si fosse concentrato nelle mie membra aumentandone la densità senza lasciare spazio a pensieri o emozioni, come uno che si muove incessantemente tra nessun posto e nessun altro e non fa assolutamente nulla se non non essere da nessuna parte, o quanto meno volerlo.
Sto in silenzio e guardo il sudore tra i peli che coprono persino le spalle al becchino, che adesso si è tolto la maglietta e sfoggia una canottiera traforata di un bel colore arancione: sta passando due cavi sotto la bara e nelle quattro maniglie laterali e ne getta le cime all’aiutante che è già risalito. Poi con un salto si aggrappa al bordo marmoreo della tomba e risale anche lui tirandosi su a forza di braccia senza usare la scaletta appoggiata alla parete. Qualche vedova e i gemelli hanno fatto alcuni passi nella nostra direzione ma si tengono ancora a prudente distanza. Allungano colli da fenicotteri e ne assumono con disinvoltura le espressioni. Si vede che ci sono portati. Meglio guardare il collo dei due uomini che stanno estraendo la bara con movimenti rallentati e sincronizzati, per non farla cadere e scoperchiare prima del tempo.
Scommetto che al becchino non dispiacerebbe (e forse nemmeno a me), ma la professionalità prima di tutto. Si volge verso di me come a chiedermi di dare una mano nel momento decisivo, quello del passaggio dal vuoto della tomba al cemento antistante, ma io fingo di non accorgermene e sto a guardare come se la cava. Voglio proprio vedere se ti viene ancora da cantarellare, adesso. La bara si piega di lato, ma prima che scivoli giù i due uomini riescono ad afferrare le maniglie alle estremità e la issano con delicatezza, nonostante il peso, fino al carrello che aspetta sul vialetto, evitando la sosta sul cemento. Il becchino mi lancia un’occhiata, ma io mi sono già voltato verso il medico e il maresciallo che hanno da poco deciso di concedere una pausa alle rispettive intelligenze. I curiosi hanno preso coraggio e ora sono a una decina di metri. I loro grugni stanno cercando espressioni più consone alla circostanza. Ci riescono benissimo: ora sono passati alla classe degli scifozoi. Posso vedere i muri del cimitero attraverso di loro, pur ammirandone la forma cardinalizia, decorativa come la danza macabra sul muro d’ingresso. Più si avvicinano allo stato minerale, meno gli uomini sono repellenti.
Seguo la bara fino alla camera mortuaria, dove verranno tolte le viti e il coperchio verrà alzato. Non credo che ci saranno saldature da dissigillare; non ho chiesto, non voglio sapere. Devo riconoscere la salma di mio padre che non ho conosciuto. Io almeno una scusa buona ce l’ho: è morto che ero ancora in fasce. Un sollievo, in fondo; col tornaconto di un periodico rimpianto che mi fa sentire più buono. Lo posso amare da lontano, senza lo scoglio della realtà, anche se a volte ascrivo la mia debolezza al fatto di non aver dovuto lottare con lui. Ma no! Non faccio altro da tutta la vita, come se fosse mia la colpa che lui si è tolto di mezzo prima. Non c’è scampo. Penso ai figli del becchino. Mi rifiuto di pensare a quelli dei due ufficiali.
Di mio padre ho visto solo qualche fotografia, e per lo più di sfuggita, perché le mie due donne, quando le sorprendevo assorte nel loro passatempo preferito, sfogliare l’album di famiglia, si sono sempre affrettate a nasconderlo per evitare i miei sarcasmi, quando non le mie sfuriate. Sono cattivo. Meno di quanto vorrei tuttavia. Adoro la perfidia, ma poiché sono affetto dalla terzana di una coscienza che inclina a imbrattarsi quando meno dovrebbe (press’a poco sempre), ne faccio un uso strettamente privato, riservandola quasi con tenerezza ai miei famigliari, come un privilegio di cui purtroppo di rado si dimostrano all’altezza. A scanso di equivoci, quindi, ho sempre interrotto le loro storie. Non sopporto l’elegia, disprezzo il tormento; e se della sua assenza, di mio padre intendo, mi sono cibato per tutti i miei cinquant’anni, ho almeno la consolazione che è stata totale. E adesso dovrei vedere quel che resta di lui, come una vendetta postuma e l’incarnazione, si fa per dire, dei rimproveri taciuti di mia madre e di quella poverina di mia sorella. Anche per me è venuto il momento di pagare il fio (loro parlano così; non rinunciano al tono, loro; non si sminuiscono come faccio io, che nascondo persino i miei titoli). Dovrei specchiarmi nella sua polvere, raccogliere commosso i brandelli del suo vestito funebre, misurare i frammenti delle sue ossa, al più qualche ciocca di peluria, fibre di cartilagini, centimetri quadri di pelle rinsecchita. Infine di mio padre non avrò conosciuto nemmeno il cadavere che per tutta la vita, secondo le regole, mi avrebbe abitato e eroso. Di questa giornata non potrò ricordare che i volti delle persone che mi accompagnano, i loro gesti, il sudore dei loro crani e le loro parole senza sordina. Ben mi sta.
Si sta bene nella fresca penombra della camera ardente, anche se preferirei che accendessero la luce, perché già che ci sono, quello che c’è da vedere lo voglio vedere chiaro. Senza accorgermi accendo una sigaretta: è un miracolo che abbia resistito tanto. Gli altri, incapaci di imitarmi, mi guardano storto, ma io non la spengo. Essendo la camera spoglia, deposito la cenere nella mia sinistra piegata a coppa, quasi rattrappita, come quelle che popolano, come un marchio troppo evidente, infinite foto di guerra. Giunto al filtro, apro la porta e la getto assieme alla cicca ancora accesa trai sassi. Il capannello dei curiosi mi spia da lontano. Alzo la testa nella loro direzione anch’io, quel tanto che basta per sostenere la loro riprovazione ma non per decifrare eventuali nuove metamorfosi. Non li voglio vedere. Voglio che si sappiano visti mentre mi guarda-no, ma non voglio vederli. Penso alle ascelle delle vedove, alle ascelle senza le vedove, poi all’odore senza le ascelle. E poi ancora all’odore che esalerà dalla bara aperta.
Ma quando rientro il coperchio è già stato tolto e di odore non ce n’è. Non c’è nemmeno profumo, per fortuna. Sento esclamazioni di meraviglia che sfuggono dalle bocche aperte dei tre uomini e dello scimunito (o dell’uomo e dei tre scimuniti; o dei quattro scimuniti e basta). Li vedo agitarsi, e l’aiutante che quasi mi travolge correndo verso la porta. Mi volto e chiudo a chiave.
Quindi mi dirigo alla bara, mentre i tre rimasti, ora in un silenzio assoluto, mi fissano con sguardo sospeso, in attesa delle mie reazioni. Non ne vedranno, non voglio dargli nessuna soddisfazione.
Il cadavere dell’uomo nella bara è intatto. Ha i capelli, i baffi e il pizzetto ben pettinati, i vestiti senza una piega, le scarpe lucide con le punte dei piedi un po’ divaricate. Due anelli gli stringono leggermente gli anulari delle mani intrecciate sul ventre. Solo la pelle ha una sfumatura grigia di troppo, ma forse è colpa della penombra. E un uomo di trent’anni, ma come gli uomini di trent’anni di una volta, che sembravano un po’ più vecchi della loro età. Potrebbe essere mio figlio; ed è come tale che lo guardo. Mio padre è mio figlio, l’ipotetico figlio che non ho voluto, e per questo non mi interessa. Sono meno curioso che se lo avessi trovato sbriciolato. Mi irrita questo suo fare il fenomeno anche da morto, secondo l’esecrabile abitudine dei padri morti giovani. Ma io non voglio irritarmi.
Piego la testa e chiudo gli occhi per respingere l’ira. Gli altri lo interpretano come una richiesta di restare solo e scivolano via ansiosi di non arrivare secondi a divulgare il portento. Hanno per lo meno l’accortezza di accostare la porta. Mi giro e la richiudo a chiave. Il movimento improvviso mi distoglie per un attimo dal controllo dell’ira, che ne approfitta per imboccare qualche scappatoia laterale e farmi perdere le sue tracce. La ritrovo troppo tardi, quando ormai ha potuto defluire in vasi secondari sconosciuti e da lì diffonder-si fino a quelli periferici, nutrendosi per strada con tutto quello che incrociava e trasformandosi in furore. Sento il furore strisciare e corrodermi come una cancrena che mi fa marcire dall’interno; i vestiti si afflosciano su di me impregnati del liquame che mi abbandona, le ossa si sfarinano, i tendini si sfilacciano, i denti cadono e il cervello trova infine la sua esatta dimensione: esattamente niente.
Intanto fuori si devono essere radunati tutti i visitatori del cimitero, forse se ne sono aggiunti altri, senza dubbio avranno già telefonato a mia madre e mia sorella. Li sento vociare, chiamarmi. Qualcuno batte i pugni sulla porta. Scorgo in un angolo un tavolino con tutti i documenti da compilare, senza accendere la lampada individuo lo spazio per le mie firme, cerco una biro nella tasca interna della giacca, ne esce una rossa, va bene lo stesso, firmo diligente-mente tutte le copie. Per me, possono scrivere quel che gli pare. Firmare mi fa bene. Quando ho finito, posso dirigermi verso la porta e andarmene.
La apro con uno scatto secco e senza dire una parola mi fermo davanti alla folla che si accalca fuori. Guardo quelli più vicini, non rispondo a domande né a saluti, aspetto che mi facciano spazio per passare. Le voci si abbassano, ma non cessano; qualcuno comincia a spostarsi, poi altri, finché si apre un varco sufficientemente ampio. Non voglio sfiorare nessuno. Aspetto ancora e infine mi dirigo verso la mia macchina. Non passerò da casa, non aspetterò le mie donne. Ne intravedo da lontano le sagome in fondo al viale d’ingresso, ma il motore ha già preso velocità. Passo loro accanto, le saluto e faccio segno con la mano che telefonerò. Ma non voglio farlo. Telefonerò invece per tentare di ricombinare l’appuntamento. E perché non dovrei riuscirci? Cosa vuoi che abbia da fare quella là? E comunque ho un sacco di cose da fare anch’io.
Qua e là i rari visitatori (il solito gruppetto di vedove che, eleganti, splendenti di una seconda, ben più felice giovinezza, si danno appuntamento al cimitero, a due a due o a tre a tre, per poi chiudere la mattinata in qualche bar; un ragazzo che smette di piangere non appena ci vede; due gemelli adulti che stanno portando dei fiori appassiti all’angolo della spazzatura) ci squadrano da lontano, indecisi se far prevalere la curiosità o la discrezione. L’oggetto della curiosità sono io, che vivo in città da più di vent’anni e, pur tornando spesso a casa di mia madre, non mi faccio vedere molto in giro. Forse qualcuno mi riconosce, o deduce chi io sia dalla tomba davanti a cui mi trovo.
Io non voglio essere qui. Mi hanno detto che la mia presenza era necessaria, che almeno un famigliare doveva assistere all’esumazione, e dietro le insistenze adeguatamente spruzzate di lacrime e preghiere di mia madre e mia sorella, che adoro, preferibilmente da lontano, sono venuto io; ma non volevo venire, e adesso che sono qui, ancora non voglio. Mia madre e mia sorella sovrintendono alla tomba chiusa, io all’apertura; loro alla normalità, al rito attossicato dal vizio pressoché quotidiano di mezzo secolo ormai, io all’effrazione. Così è stabilito, e io mi adeguo come meglio posso, costante nell’incostanza, schiacciato dalla leggerezza dell’assenza di vincoli evidenti che ha finito per appesantire anche i miei lineamenti una volta belli e questo corpo, che porto in giro come un pacco postale lasciatomi in deposito da qualcuno che poi non si è fatto più vedere, un povero corpo che non ha mai danzato.
Mentre becchino e aiutante si godono un po’ di fresco nella tomba della mia famiglia prima di estrarre la cassa dal suo alloggiamento e di metterla su due cavalletti previamente calati fino al pavimento, penso alla donna che avrei dovuto incontrare questa sera se non avessi rinviato l’appuntamento, e penso anche che avrei potuto rispettarlo, se avessi voluto, tanto le pratiche non dureranno a lungo; ma adesso non vorrei essere nemmeno con lei. Non voglio essere da nessuna parte. Mi sento, come mi capita spesso, ma con più forza, quasi che tutto (tutto cosa?) si fosse concentrato nelle mie membra aumentandone la densità senza lasciare spazio a pensieri o emozioni, come uno che si muove incessantemente tra nessun posto e nessun altro e non fa assolutamente nulla se non non essere da nessuna parte, o quanto meno volerlo.
Sto in silenzio e guardo il sudore tra i peli che coprono persino le spalle al becchino, che adesso si è tolto la maglietta e sfoggia una canottiera traforata di un bel colore arancione: sta passando due cavi sotto la bara e nelle quattro maniglie laterali e ne getta le cime all’aiutante che è già risalito. Poi con un salto si aggrappa al bordo marmoreo della tomba e risale anche lui tirandosi su a forza di braccia senza usare la scaletta appoggiata alla parete. Qualche vedova e i gemelli hanno fatto alcuni passi nella nostra direzione ma si tengono ancora a prudente distanza. Allungano colli da fenicotteri e ne assumono con disinvoltura le espressioni. Si vede che ci sono portati. Meglio guardare il collo dei due uomini che stanno estraendo la bara con movimenti rallentati e sincronizzati, per non farla cadere e scoperchiare prima del tempo.
Scommetto che al becchino non dispiacerebbe (e forse nemmeno a me), ma la professionalità prima di tutto. Si volge verso di me come a chiedermi di dare una mano nel momento decisivo, quello del passaggio dal vuoto della tomba al cemento antistante, ma io fingo di non accorgermene e sto a guardare come se la cava. Voglio proprio vedere se ti viene ancora da cantarellare, adesso. La bara si piega di lato, ma prima che scivoli giù i due uomini riescono ad afferrare le maniglie alle estremità e la issano con delicatezza, nonostante il peso, fino al carrello che aspetta sul vialetto, evitando la sosta sul cemento. Il becchino mi lancia un’occhiata, ma io mi sono già voltato verso il medico e il maresciallo che hanno da poco deciso di concedere una pausa alle rispettive intelligenze. I curiosi hanno preso coraggio e ora sono a una decina di metri. I loro grugni stanno cercando espressioni più consone alla circostanza. Ci riescono benissimo: ora sono passati alla classe degli scifozoi. Posso vedere i muri del cimitero attraverso di loro, pur ammirandone la forma cardinalizia, decorativa come la danza macabra sul muro d’ingresso. Più si avvicinano allo stato minerale, meno gli uomini sono repellenti.
Seguo la bara fino alla camera mortuaria, dove verranno tolte le viti e il coperchio verrà alzato. Non credo che ci saranno saldature da dissigillare; non ho chiesto, non voglio sapere. Devo riconoscere la salma di mio padre che non ho conosciuto. Io almeno una scusa buona ce l’ho: è morto che ero ancora in fasce. Un sollievo, in fondo; col tornaconto di un periodico rimpianto che mi fa sentire più buono. Lo posso amare da lontano, senza lo scoglio della realtà, anche se a volte ascrivo la mia debolezza al fatto di non aver dovuto lottare con lui. Ma no! Non faccio altro da tutta la vita, come se fosse mia la colpa che lui si è tolto di mezzo prima. Non c’è scampo. Penso ai figli del becchino. Mi rifiuto di pensare a quelli dei due ufficiali.
Di mio padre ho visto solo qualche fotografia, e per lo più di sfuggita, perché le mie due donne, quando le sorprendevo assorte nel loro passatempo preferito, sfogliare l’album di famiglia, si sono sempre affrettate a nasconderlo per evitare i miei sarcasmi, quando non le mie sfuriate. Sono cattivo. Meno di quanto vorrei tuttavia. Adoro la perfidia, ma poiché sono affetto dalla terzana di una coscienza che inclina a imbrattarsi quando meno dovrebbe (press’a poco sempre), ne faccio un uso strettamente privato, riservandola quasi con tenerezza ai miei famigliari, come un privilegio di cui purtroppo di rado si dimostrano all’altezza. A scanso di equivoci, quindi, ho sempre interrotto le loro storie. Non sopporto l’elegia, disprezzo il tormento; e se della sua assenza, di mio padre intendo, mi sono cibato per tutti i miei cinquant’anni, ho almeno la consolazione che è stata totale. E adesso dovrei vedere quel che resta di lui, come una vendetta postuma e l’incarnazione, si fa per dire, dei rimproveri taciuti di mia madre e di quella poverina di mia sorella. Anche per me è venuto il momento di pagare il fio (loro parlano così; non rinunciano al tono, loro; non si sminuiscono come faccio io, che nascondo persino i miei titoli). Dovrei specchiarmi nella sua polvere, raccogliere commosso i brandelli del suo vestito funebre, misurare i frammenti delle sue ossa, al più qualche ciocca di peluria, fibre di cartilagini, centimetri quadri di pelle rinsecchita. Infine di mio padre non avrò conosciuto nemmeno il cadavere che per tutta la vita, secondo le regole, mi avrebbe abitato e eroso. Di questa giornata non potrò ricordare che i volti delle persone che mi accompagnano, i loro gesti, il sudore dei loro crani e le loro parole senza sordina. Ben mi sta.
Si sta bene nella fresca penombra della camera ardente, anche se preferirei che accendessero la luce, perché già che ci sono, quello che c’è da vedere lo voglio vedere chiaro. Senza accorgermi accendo una sigaretta: è un miracolo che abbia resistito tanto. Gli altri, incapaci di imitarmi, mi guardano storto, ma io non la spengo. Essendo la camera spoglia, deposito la cenere nella mia sinistra piegata a coppa, quasi rattrappita, come quelle che popolano, come un marchio troppo evidente, infinite foto di guerra. Giunto al filtro, apro la porta e la getto assieme alla cicca ancora accesa trai sassi. Il capannello dei curiosi mi spia da lontano. Alzo la testa nella loro direzione anch’io, quel tanto che basta per sostenere la loro riprovazione ma non per decifrare eventuali nuove metamorfosi. Non li voglio vedere. Voglio che si sappiano visti mentre mi guarda-no, ma non voglio vederli. Penso alle ascelle delle vedove, alle ascelle senza le vedove, poi all’odore senza le ascelle. E poi ancora all’odore che esalerà dalla bara aperta.
Ma quando rientro il coperchio è già stato tolto e di odore non ce n’è. Non c’è nemmeno profumo, per fortuna. Sento esclamazioni di meraviglia che sfuggono dalle bocche aperte dei tre uomini e dello scimunito (o dell’uomo e dei tre scimuniti; o dei quattro scimuniti e basta). Li vedo agitarsi, e l’aiutante che quasi mi travolge correndo verso la porta. Mi volto e chiudo a chiave.
Quindi mi dirigo alla bara, mentre i tre rimasti, ora in un silenzio assoluto, mi fissano con sguardo sospeso, in attesa delle mie reazioni. Non ne vedranno, non voglio dargli nessuna soddisfazione.
Il cadavere dell’uomo nella bara è intatto. Ha i capelli, i baffi e il pizzetto ben pettinati, i vestiti senza una piega, le scarpe lucide con le punte dei piedi un po’ divaricate. Due anelli gli stringono leggermente gli anulari delle mani intrecciate sul ventre. Solo la pelle ha una sfumatura grigia di troppo, ma forse è colpa della penombra. E un uomo di trent’anni, ma come gli uomini di trent’anni di una volta, che sembravano un po’ più vecchi della loro età. Potrebbe essere mio figlio; ed è come tale che lo guardo. Mio padre è mio figlio, l’ipotetico figlio che non ho voluto, e per questo non mi interessa. Sono meno curioso che se lo avessi trovato sbriciolato. Mi irrita questo suo fare il fenomeno anche da morto, secondo l’esecrabile abitudine dei padri morti giovani. Ma io non voglio irritarmi.
Piego la testa e chiudo gli occhi per respingere l’ira. Gli altri lo interpretano come una richiesta di restare solo e scivolano via ansiosi di non arrivare secondi a divulgare il portento. Hanno per lo meno l’accortezza di accostare la porta. Mi giro e la richiudo a chiave. Il movimento improvviso mi distoglie per un attimo dal controllo dell’ira, che ne approfitta per imboccare qualche scappatoia laterale e farmi perdere le sue tracce. La ritrovo troppo tardi, quando ormai ha potuto defluire in vasi secondari sconosciuti e da lì diffonder-si fino a quelli periferici, nutrendosi per strada con tutto quello che incrociava e trasformandosi in furore. Sento il furore strisciare e corrodermi come una cancrena che mi fa marcire dall’interno; i vestiti si afflosciano su di me impregnati del liquame che mi abbandona, le ossa si sfarinano, i tendini si sfilacciano, i denti cadono e il cervello trova infine la sua esatta dimensione: esattamente niente.
Intanto fuori si devono essere radunati tutti i visitatori del cimitero, forse se ne sono aggiunti altri, senza dubbio avranno già telefonato a mia madre e mia sorella. Li sento vociare, chiamarmi. Qualcuno batte i pugni sulla porta. Scorgo in un angolo un tavolino con tutti i documenti da compilare, senza accendere la lampada individuo lo spazio per le mie firme, cerco una biro nella tasca interna della giacca, ne esce una rossa, va bene lo stesso, firmo diligente-mente tutte le copie. Per me, possono scrivere quel che gli pare. Firmare mi fa bene. Quando ho finito, posso dirigermi verso la porta e andarmene.
La apro con uno scatto secco e senza dire una parola mi fermo davanti alla folla che si accalca fuori. Guardo quelli più vicini, non rispondo a domande né a saluti, aspetto che mi facciano spazio per passare. Le voci si abbassano, ma non cessano; qualcuno comincia a spostarsi, poi altri, finché si apre un varco sufficientemente ampio. Non voglio sfiorare nessuno. Aspetto ancora e infine mi dirigo verso la mia macchina. Non passerò da casa, non aspetterò le mie donne. Ne intravedo da lontano le sagome in fondo al viale d’ingresso, ma il motore ha già preso velocità. Passo loro accanto, le saluto e faccio segno con la mano che telefonerò. Ma non voglio farlo. Telefonerò invece per tentare di ricombinare l’appuntamento. E perché non dovrei riuscirci? Cosa vuoi che abbia da fare quella là? E comunque ho un sacco di cose da fare anch’io.