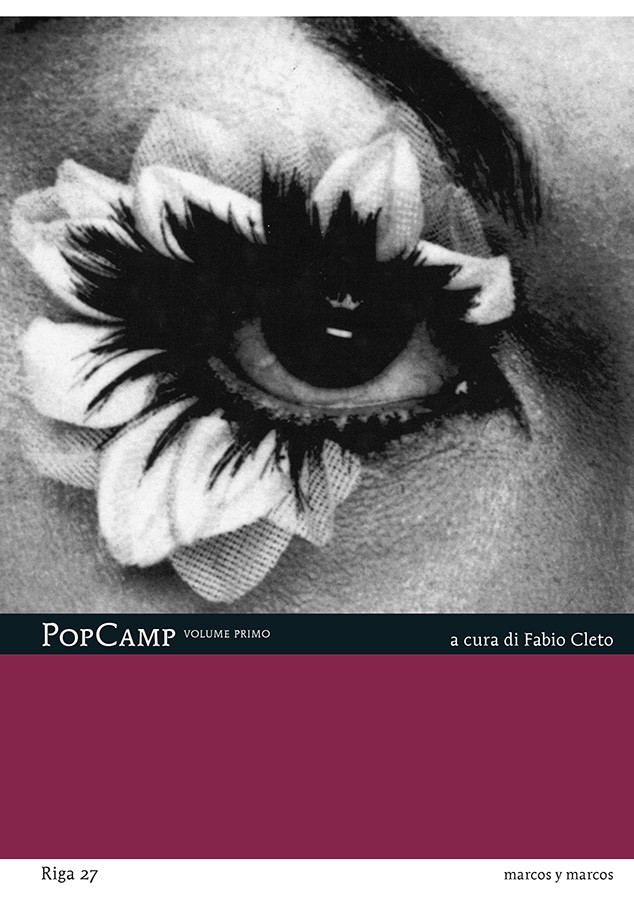Gregory Woods
Alla ricerca del camp italiano
Alla ricerca del camp italiano
Quando visitai Napoli per la prima volta nel 1981, trascorsi un’ora intera in contemplazione di un giovane agente di polizia che dirigeva il traffico all’uscita del Museo Nazionale.
La sua gestualità biancoguantata era teatrale ma precisa, quasi si trattasse di un mimo. Aveva lunghi, folti baffi (il che, all’epoca, era molto gay in Gran Bretagna così come negli Stati Uniti), la sua uniforme era tagliata in modo assai elegante e cantava a voce altissima. Potrebbe trattarsi di un pio desiderio retroattivo più che di eccellente memoria da parte mia, ma mi pare cantasse Verdi. Il mio primo istinto fu quello di vedere in questa performance uno splendido esempio di High Camp, di camp quintessenziale.
Giunsi poi alla conclusione che si trattava solo di High Neapolitan, di ‘quintessenziale napoletano’. Da allora, però, ho cambiato idea.
Molti altri esempi di questo ‘problema’ (tale era per me, se non altro) si sono palesati nel corso degli anni successivi. Non sono sicuro di avere l’autorità per determinare se (come sospetto) il puro eccesso dell’Aida sia camp, laddove i momenti conclusivi della Cavalleria rusticana sono semplicemente melodrammatici. Raccolgo perciò queste idee insieme a tutte le altre impressioni cui non riesco a dar forma. Analogamente, sebbene io abbia sempre ritenuto impossibile la lettura di García Lorca se non attraverso il filtro del camp, è probabile che mi siano sfuggite caratteristiche che sono semplicemente spagnole: non mi sento esattamente in grado di distinguere quali aspetti della sua opera siano cattolici, oppure queer, o specificamente di Granada.
Ho sempre sospettato che uno sguardo gay di lingua inglese (o anglosassone protestante) possa percepire nella cultura mediterranea e latino-americana degli elementi camp che in realtà, all’interno di tali culture, non sono affatto visti come tali. Per questo mi stupisce particolarmente scoprire come due libri inglesi sul camp, per quanto ampio sia lo spettro che coprono, siano tanto avari nei riferimenti alla cultura italiana.
Né Mark Booth in Camp (1983) né Philip Core in Camp: The Lie that Tells the Truth (1984) hanno molto da dire riguardo agli italiani. Booth menziona l’Aretino, il Carpaccio, la Mar-chesa Luisa Casati, Castiglione, Mussolini, il Parmigianino, Francesco Primaticcio, Gregory Woods Alla ricerca del camp italiano 590 Gregory Woods - Alla ricerca del camp italiano Rosso Fiorentino, Francesco e Jacopo Sansovino e Luchino Visconti. Core elenca nel suo dizionario camp Giorgio Armani, il Bronzino, i Carracci, Caravaggio, Luisa Casati, D’Annunzio, Fellini, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pontormo, Elsa Schiaparelli e, a sua volta, Visconti. Vale la pena sottolineare che gran parte di questi sono artisti figurativi, dei quali ci si può aspettare che l’Italia abbondi. Eppure, entrambi gli autori sono assai più propensi a identificare esempi di camp nella cultura francese, e in quella tedesca. Gli unici italiani menzionati in entrambi i testi sono la Casati e Visconti.
Per quel che mi riguarda, i nomi di Michelangelo e Leonardo, in particolare, mi mettono sul chi vive. Qual è il motivo - oltre al fatto che erano ciò che oggi si dice omosessuali - per cui sono stati inclusi nell’elenco di Core? Che cosa esattamente è camp nella loro opera (o vita)? Philip Core non risolve la questione. Riguardo a Michelangelo dice che, benché «ov-viamente omosessuale», «non era camp». La sua opera è caratterizzata da una «manifesta ambiguità» (ma quale opera di un grande artista non lo è?); tuttavia Core colloca il camp non nell’opera ma nella sua successiva circolazione. Parla di un’«ossessione kitsch» per l’opera di Michelangelo «che, presso i suoi estimatori omosessuali, si doveva tradurre in un’idolatria camp» per la monumentale figura del David. Come possa una statua né Kitsch né camp suscitare nel pubblico un’«ossessione kitsch» che presso i gay si affina in «idolatria camp», è un meccanismo che Core non si degna di illustrare.
Le cose rimangono poco chiare anche quando Core rivolge l’attenzione a Leonardo.
Sebbene esordisca, con riferimento a una nota controversia, invitando a «non cavillare sul fatto che fosse omosessuale o meno», Core aggiunge immediatamente che l’artista era in effetti «chiaramente omosessuale». Dichiara poi di non voler «analizzare le sue opere alla ricerca di segni d’omosessualità», ma osserva che «a tratti Leonardo è semplicemente camp». La questione non è però così semplice, poiché Core prosegue sostenendo che «Le-onardo è ciò che potrei definire seriamente camp, distinguendolo dallo high camp, che per tradizione significa una frivolezza scatenata». Sembra voler individuare questa versione di camp nella rappresentazione ‘ermafrodita’ del San Giovanni Battista e della Vergine con bambino e Sant’Anna, da cui evince che il pittore «ovviamente, la maternità la sentiva dall’interno». Altro però non è dato sapere.
Tali conclusioni sono strane quanto le inevitabili omissioni. Proprio non riesco a capire perché né Booth né Core abbiano tenuto conto di Giulio Romano, per citare uno dei miei esempi preferiti. (Sto pensando al connubio di erotismo e grottesco negli affreschi di Pa-lazzo Té a Mantova, al finto rustico della sua architettura, alla scena della disfatta nella Sala dei Giganti…) Ma ognuno di noi ha le proprie preferenze, e come trovare una definizione che le includa tutte? Il problema si lega in parte al fatto che chi usa camp come termine critico si concede di indulgere nella stessa frivolezza che caratterizza il suo oggetto di studio. Riluttanti a definire in modo inequivocabile la propria parola chiave, lasciamo che la parola camp significhi qualsiasi cosa si desideri; e il significato non è mai lo stesso. A volte si manifesta nelle intenzioni dell’artista; a volte va cercato nello sguardo del fruitore. Si trova nella vita o nell’opera. È gay oppure no. Sconfina in culture e periodi storici differenti, incurante delle nette distinzioni; forse però non bisognerebbe consentirglielo…
Susan Sontag riteneva che le considerazioni sul camp di Christopher Isherwood in Il mon-do di sera (1954) fossero «pigre». Tuttavia le sue famose Note sul ‘Camp’ (1964), a dispetto di tutta la loro perspicacia, non seguono una linearità argomentativa. (E in tal senso le ‘note’ sono caratteristiche di molti dei migliori ‘saggi’ della Sontag.) Alla stessa stregua, il testo di Core si presenta come un elenco alfabetico privo di un filo conduttore.
Nel parlare di camp, ci ritroviamo così confusi e impacciati, vaneggiamo e cadiamo in con-traddizione.
Sebbene l’intento non sia qui quello di «dissezionare una farfalla» (per usare l’espressione di Alexander Pope), è chiaro che il camp non può più essere considerato una mera farfalla, per quanto alcune delle sue manifestazioni possano essere tanto belle quanto fragili. Negli ultimi decenni un’ampia parte della cultura popolare deriva da tentativi di diffondere un’estetica camp, e assai numerose sono le opere d’arte ricondotte a tale quadro estetico: risulta perciò imprescindibile confrontarsi con questa categoria. Se la Sontag aveva ragione (e l’aveva), oltre quarant’anni fa, a identificare nel camp uno dei fattori cruciali della cultu-ra moderna, gli anni a seguire lo hanno rivelato elemento ancor più fondamentale nella cultura del postmodernismo, del consumismo e della globalizzazione. Se ne evince, a rigor di logica, che il camp trova la propria straordinaria forza nella sua ubiquità.
Forse io non sono in grado, per certi versi, di delibare una tale fonte del favoloso.
Ho sempre avuto del camp un’esperienza assai scettica e parca. Sembra che io sia molto meno propenso, rispetto ad altri gay, a dire di una qualsiasi cosa, «Oh, è talmente camp!». Ma la pervasività del camp è terribilmente persuasiva. Una volta che si sia analizzato un qualsiasi artefatto, o una performance, ai molteplici livelli d’ironia che scaturiscono dalle molte possibili fonti che vi sono implicate (a partire da produttore e consumatore), persino una totale assenza di ironia, persino l’innocenza più primordiale può essere accolta con maliziosa sagacia da un pubblico assetato di camp. Qual è quell’elemento così raffinato da rimanere immune al processo alchemico che, nel momento esatto in cui si osa dire che una tal cosa non è camp, trasforma quella stessa cosa in camp - o se non altro, che stranamente estende la nostra definizione di camp così da costringerci a comprenderla? Com’è possi-bile escludere qualcosa da questo pantheon dello splendore equivoco, che sembra espandersi con lo stesso vigore dell’universo dopo il Big Bang? Non riesco a non pensare a un medico che una volta mi rimproverò, all’epoca gloriosa della mia promiscuità, con un severo motto: «Non esiste nulla che non sia venereo!». Quando penso all’argomento in que-stione, sono indotto a un analogo estremismo: forse non esiste nulla che non sia camp.
Una tale affermazione merita di essere messa alla prova. Se dovessi citare un artista che non è camp, o che non lo è stato mai, mi viene subito in mente Beethoven. Ma poi mi sovviene la Fantasia Corale (op. 80), che fa sfoggio di una gamma di virtuosismi inconciliabili, utilizzando - in venti minuti di consapevole arguzia - strane combinazioni di forze e convenzioni. Se non Beethoven, allora chi? Rembrandt? Confesso di essere ancora alla ricerca del camp in Rembrandt, ma temo proprio che salterà fuori, prima o poi. Fra i modernisti sono tentato di fare il nome di Kandinskij, fino a quando non faccio mente locale alle Baga-telle che dipinse a Stoccolma verso la fine del 1915. E così la ricerca continua. Ma se non un’intera produzione artistica, devono pur esserci singoli lavori di cui si possa affermare con assoluta autorità: qui non c’è traccia di camp. Alla ricerca di tesori così peculiari, mi rivolgo inevitabilmente a esempi di straordinario contegno: il Beato Angelico, Antonello da Messina, la sesta sinfonia di Jean Sibelius, le storie di Borges…
Tuttavia, poiché il contegno tende all’austerità e diviene materia di compiacimento e orgoglio, può ben produrre eccessi e stravaganze. (Non ci meraviglia che l’Inquisizione spagnola sia passata senza difficoltà nei raccapriccianti orrori del romanzo gotico inglese. E non ci meraviglia nemmeno che gli affascinanti malvagi del gotico, in gran parte, siano o spagnoli o italiani.) Il punto è che non basta escludere l’ornamento, l’elaborazione e la decorazione per escludere il camp, men che meno quando uno stile asciutto risulta in sé straordinariamente espansivo. Si pensi alle posizioni ostentatamente dichiarative del minimalismo: John Cage, Carl Andre, gli ultimi lavori di Samuel Beckett…
L’accenno all’Inquisizione ci ricorda - così come molti impulsi contraddittori dell’Islam (per esempio: fare un attentato suicida per godersi le vergini in Paradiso) - che lusso e au-sterità spesso si intrecciano, e quando ciò avviene, l’esito è carico di camp. In Donatello, per esempio, è la medesima sensibilità a dare origine alla lugubre anoressia di Maria Maddalena e all’assurdo copricapo del David nudo. E tuttavia, non è proprio in questa capacità di conciliare e rappresentare visioni del modo diametralmente opposte - l’Umanesimo e la Cristianità - che si trova il fulcro del Rinascimento? Non è questa potenziale spaccatura il fattore più promettente per la produzione di camp? È quanto senza dubbio accade nel Barocco, quando questo inizia a produrre le proprie storie di santità.
Se mi fosse chiesto d’indicare le apoteosi di camp italiano, credo infatti che dovrei assolutamente includere l’Estasi di Santa Teresa nella Cappella Cornaro a Roma. Non solo per l’evidente allusione sessuale (fin troppo facile e banale oggi associare l’estasi religiosa a un generoso orgasmo femminile), sebbene, lo ammetto, questa non sia del tutto irrilevante: è pure una questione di forma e materiali. Nella sua Ars Poetica Orazio sosteneva che i poeti dovrebbero astenersi dal prendersi certe libertà - «al punto d’accoppiare una serpe ed un uccello, la pecora e la tigre, e così via» - ma questo è proprio quanto tende a fare l’artista camp. L’ambientazione della Santa Teresa è piena di giustapposizioni incongrue nel suo compendio di materiali e stili (legno, stucco, marmo bianco e colorato, architettura, pittu-ra, luce…) e nel suo uso di materiali impropri (nuvole di pietra, luce di legno dorato). Committenti e mecenati dello scultore fanno da astanti nei loro palchetti laterali, quali voyeur di un momento privato reso spettacolarmente pubblico. L’opera richiede un accompagnamento musicale - non importa che si tratti di Bellini o di Donna Summer - anche solo per incrementare il novero dei sensi che fanno i conti con la sua impudenza. (Ben-ché gran parte della sensazione di teatralità che ci suscita dipenda, anacronisticamente, dalla storia del teatro successivo, possiamo confortarci ricordando che lo stesso Bernini era anche scenografo teatrale.) Teresa è chiaramente una peccatrice en travesti da santa: quella scultura è un’interpretazione del piacere spirituale da parte di una diva palpabilmente fisica, ed esibizionista.
Detto ciò, comunque, la scultura - anche quella di Bernini, anche se mossa da effetti di luce o dall’acqua che scorre, come nella fontane di Piazza Navona - mi pare un’arte troppo statica per rappresentare il camp italiano. A dispetto della grandezza dei maestri del mar-mo e del bronzo, può darsi che i migliori esempi di camp giungano dall’Italia. L’industria della moda milanese fa qui la sua parte - e chi sa dirci perché,
tra tutti e due, Mark Booth e Philip Core sono stati in grado di nominare, tra gli stilisti italiani, solo Armani ed Elsa Schiaparelli? - al pari dell’industria cinematografica di Cinecittà; e, certo, dell’opera. Ma strano a dirsi, se devo evocare le mie immagini predilette di camp italiano, mi vengono in mente due scene che hanno scrittori per protagonisti: Ga-briele D’Annunzio al Vittoriale, che per curare Tamara de Lempicka, febbricitante dopo una gita in aereo, la spennella nuda per giorni con il membro turgido; e Curzio Malaparte in esilio a Lipari per aver denigrato i gusti del Duce in fatto di cravatte. (Nell’ultima scena, mi chiedo, quale dei due contendenti è più camp?). Ma il camp italiano è ben più che una serie di individui eccellenti. Intere città sono camp, a partire dalla stessa Roma, con il suo sgargiante palinsesto di classicismo, cattolicesimo e fascismo. Vi sono poi i caratteristici piccoli dettagli della quotidianità - un funerale che si ferma al semaforo a Venezia, il vigile che canta Verdi a Napoli - oppure alcuni paesaggi urbani: l’Italia presenta infatti alcune delle più belle disposizioni al mondo dello spazio pubblico, sia esterno sia interno. Far quattro passi alla volta di un ristorante in Galleria Vittorio Emanuele dopo una serata alla Scala (a vedere la Norma, ad esempio), andare ‘a caccia’ sulla piazza per poi fare una capatina nel Duomo a pentirsi un poco: persino la persona più insensibile, prima o poi, sarebbe toccata in questa passeggiata dalla bacchetta magica del camp. Mentre in Inghilterra una passeggiata viene intrapresa, quando proprio è necessario, in nome dell’esercizio fisico, in Italia la si fa per amor di spettacolo. Walt Whitman colse qualcosa di questo spirito nella Manhattan di metà Ottocento, così come Baudelaire fece a Parigi. Paragonato al protestantesimo dei paesi del Nord, ovviamente, il cattolicesimo meridionale è intrinsecamente, in-correggibilmente camp. Ronald Firbank, quello spaurito Orlando curioso dell’effeminatezza ilare, lo sapeva bene e si beava nelle chiese di Roma, mentre a Londra si doveva accontentare del Café Royal. Gli omosessuali del Nord protestante sono da sempre attratti dall’atmosfera tutta ‘scampanii e profumi’ del cattolicesimo romano - ovvero dalla sua ritualità avvolta d’incenso, dall’abbigliamento teatrale e dall’allestimento roboante del-le sue chiese - così come dal culto mariano e dall’adorazione della figura materna in gene-rale. In Inghilterra, cattolicesimo romano e camp si sono accompagnati non solo nei ro-manzi di Firbank, ma anche nelle opere ben più note che essi hanno influenzato: la commedia sconfinante in nostalgico zelo di Evelyn Waugh (specialmente in Ritorno a Bride-shead, il cui omoerotismo pastorale cede il passo a un cerimonioso, eterosessuale cattolicesimo romano che si rivela ancor più camp, e non di poco); il cattolicesimo scettico di Gra-ham Greene; Muriel Spark e i suoi rebus postmoderni sul Libero Arbitrio garantito dall’Onnipotente, che di divinità o autore si tratti…
Ogni versione sovverte e converte quelle da cui trae origine.
Il locus classicus del camp mi pare si situi lungo la precaria faglia tra versioni così discrepanti di un tema e una pratica così comuni. Un artista capovolge l’opera di un altro, come accade a Palazzo Chiericati del Palladio a Vicenza: già di per sé un’inversione delle conven-zioni proprie alle corti del palazzo romano, viene ulteriormente complicata da Inigo Jones nella Queen’s House a Greenwich. Qualcosa di analogo, sebbene meno elegante, accade con la scultrice britannica Rachel Whiteread, che realizza la sua House (1993) facendo un calco in cemento di un ordinario edificio vittoriano a Londra.
Non è semplicemente una questione di intertestualità, ma di interazione tra immaginari distinti. L’effetto è ancora più sconvolgente quando si infrangono i confini fra epoche e culture.
Simili mutamenti hanno luogo nella storia intertestuale di Der Tod in Venedig (1913), lugubre racconto di un estetismo casto e raffinato custodito nel corpo di un quattordicenne. Il Tadzio di Thomas Mann è esile e malaticcio; la sua vulnerabilità lo rende vittima dei compagni, gli stessi peraltro a rincuorarlo nei momenti di sconforto. Nella versione più carnale di Luchino Visconti, Morte a Venezia (1971), per contrasto, l’adolescente assume i tratti languidi e formosi di Björn Andrésen, avviluppati dalla voluttuosa malinconia dell’Adagietto di Mahler e offuscati solamente dall’opulenza di Silvana Mangano. Lo splendore barocco del film è valorizzato dal modo in cui Visconti rende irrequieta la macchina da presa ogniqualvolta si trovi nelle vicinanze di un ragazzo, un abito o uno specchio. L’eloquente verbosità del romanzo si trasforma insomma nella seduzione visiva di un lus-sureggiante Liebestod. Tadzio diventerà poi aitante pentatleta nell’opera di Benjamin Britten, Death in Venice (1973). Nei «Giochi di Apollo» che chiudono il primo atto, danzati sulle note esotiche di un gamelan in versione pastiche, supera sistematicamente gli amici in ogni competizione: corsa, salto in lungo, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Non viene fornita spiegazione alcuna a questa superiorità, che si pone in netto contrasto sia con la scena che precede (in cui Tadzio è colpito e atterrato dal compagno più robusto, Jaschiu, e deve essere portato a braccia dalla madre che lo consolerà) sia con la scena finale dell’opera (in cui Aschenbach morente guarda Jaschiu premere il viso di Tadzio nella sabbia). Ovviamente queste attività atletiche non sono vere competizioni, giacché le coreografie di Frederick Ashton non lasciano nulla al caso: il più piccolo movimento è studiato e provato più volte, in modo tale da garantire l’assoluta precisione della performance. In modo cruciale, diverse forme di omosessualità entrano così in gioco in questa sequenza di testi: la paterna pedofilia post-freudiana di Mann; quella fraterna, postkinseyana, di Brit-ten; l’omosessualità di gran lunga più ostentata, ancorché opposta al liberazionismo gay, di Visconti e Ashton, che dedicano attenzione all’elemento virile più che a quello puerile… Riunite nel dare forma a differenti versioni del medesimo racconto, le loro sensibilità inconciliabili - lungi dal prendere le mosse da un’unitaria Weltanschauung ‘gay’ - entrano talmente in attrito e in contraddizione l’una con l’altra da riuscire a dar vita a un agglome-rato di ‘morti-a-Venezia’ nel quale non è dato identificare una versione definitiva, poiché ognuna si rivela produttivamente densa di difetti e incongruenze. Ne scaturisce in sostanza un’innata instabilità che mi piacerebbe definire camp.
C’è stato un momento in cui ho preso in considerazione Dante quale candidato al ruolo di artista non-camp, ma è un’ipotesi subito svanita. La forza della trilogia del poeta americano James Merrill, The Changing Light at Sandover (1976, 1978, 1980), deriva in larga parte dalla sua deliberata minaccia di banalizzare la struttura della Divina Commedia pur man-tenendone intatta la profondità tematica. Il fatto che Merrill e il suo compagno David Ja-ckson visitino il regno dell’aldilà solo per procura - con una tavoletta per sedute spiritiche e l’aiuto di uno spirito guida - conferisce ai loro dialoghi con i defunti un’intimità domestica che, pur aprendo un conflitto con le nozioni convenzionali di grandiosità escatologica e sminuendo la solennità a cui Omero, Milton, Blake e lo stesso Dante ci hanno abituato, riesce a conservare intatta la serietà delle tematiche. Tale pratica appare del resto già in parte nel modo in cui Dante sviluppò a fini cristiani la topica pagana della discesa agli inferi. Non vi è forse, dopotutto, qualche cosa di ineffabilmente camp nelle pettegole beghe della Divina Commedia, elevate dal virtuosismo di Dante (nonché dalla sua fede) quasi al livello di una teologia? E che dire poi di una celebre faccenda di dettaglio, l’esclamazione di Brunetto Latini «Qual maraviglia!» mentre prende Dante «per lo lembo» della veste (Inferno xv)? Non si ha forse un piacere particolare nel sapere che persino nei gironi infernali si può apprezzare un panno che giunge dal regno mondano?
Traduzione di Stefania Consonni e Marta Pianeti
La sua gestualità biancoguantata era teatrale ma precisa, quasi si trattasse di un mimo. Aveva lunghi, folti baffi (il che, all’epoca, era molto gay in Gran Bretagna così come negli Stati Uniti), la sua uniforme era tagliata in modo assai elegante e cantava a voce altissima. Potrebbe trattarsi di un pio desiderio retroattivo più che di eccellente memoria da parte mia, ma mi pare cantasse Verdi. Il mio primo istinto fu quello di vedere in questa performance uno splendido esempio di High Camp, di camp quintessenziale.
Giunsi poi alla conclusione che si trattava solo di High Neapolitan, di ‘quintessenziale napoletano’. Da allora, però, ho cambiato idea.
Molti altri esempi di questo ‘problema’ (tale era per me, se non altro) si sono palesati nel corso degli anni successivi. Non sono sicuro di avere l’autorità per determinare se (come sospetto) il puro eccesso dell’Aida sia camp, laddove i momenti conclusivi della Cavalleria rusticana sono semplicemente melodrammatici. Raccolgo perciò queste idee insieme a tutte le altre impressioni cui non riesco a dar forma. Analogamente, sebbene io abbia sempre ritenuto impossibile la lettura di García Lorca se non attraverso il filtro del camp, è probabile che mi siano sfuggite caratteristiche che sono semplicemente spagnole: non mi sento esattamente in grado di distinguere quali aspetti della sua opera siano cattolici, oppure queer, o specificamente di Granada.
Ho sempre sospettato che uno sguardo gay di lingua inglese (o anglosassone protestante) possa percepire nella cultura mediterranea e latino-americana degli elementi camp che in realtà, all’interno di tali culture, non sono affatto visti come tali. Per questo mi stupisce particolarmente scoprire come due libri inglesi sul camp, per quanto ampio sia lo spettro che coprono, siano tanto avari nei riferimenti alla cultura italiana.
Né Mark Booth in Camp (1983) né Philip Core in Camp: The Lie that Tells the Truth (1984) hanno molto da dire riguardo agli italiani. Booth menziona l’Aretino, il Carpaccio, la Mar-chesa Luisa Casati, Castiglione, Mussolini, il Parmigianino, Francesco Primaticcio, Gregory Woods Alla ricerca del camp italiano 590 Gregory Woods - Alla ricerca del camp italiano Rosso Fiorentino, Francesco e Jacopo Sansovino e Luchino Visconti. Core elenca nel suo dizionario camp Giorgio Armani, il Bronzino, i Carracci, Caravaggio, Luisa Casati, D’Annunzio, Fellini, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pontormo, Elsa Schiaparelli e, a sua volta, Visconti. Vale la pena sottolineare che gran parte di questi sono artisti figurativi, dei quali ci si può aspettare che l’Italia abbondi. Eppure, entrambi gli autori sono assai più propensi a identificare esempi di camp nella cultura francese, e in quella tedesca. Gli unici italiani menzionati in entrambi i testi sono la Casati e Visconti.
Per quel che mi riguarda, i nomi di Michelangelo e Leonardo, in particolare, mi mettono sul chi vive. Qual è il motivo - oltre al fatto che erano ciò che oggi si dice omosessuali - per cui sono stati inclusi nell’elenco di Core? Che cosa esattamente è camp nella loro opera (o vita)? Philip Core non risolve la questione. Riguardo a Michelangelo dice che, benché «ov-viamente omosessuale», «non era camp». La sua opera è caratterizzata da una «manifesta ambiguità» (ma quale opera di un grande artista non lo è?); tuttavia Core colloca il camp non nell’opera ma nella sua successiva circolazione. Parla di un’«ossessione kitsch» per l’opera di Michelangelo «che, presso i suoi estimatori omosessuali, si doveva tradurre in un’idolatria camp» per la monumentale figura del David. Come possa una statua né Kitsch né camp suscitare nel pubblico un’«ossessione kitsch» che presso i gay si affina in «idolatria camp», è un meccanismo che Core non si degna di illustrare.
Le cose rimangono poco chiare anche quando Core rivolge l’attenzione a Leonardo.
Sebbene esordisca, con riferimento a una nota controversia, invitando a «non cavillare sul fatto che fosse omosessuale o meno», Core aggiunge immediatamente che l’artista era in effetti «chiaramente omosessuale». Dichiara poi di non voler «analizzare le sue opere alla ricerca di segni d’omosessualità», ma osserva che «a tratti Leonardo è semplicemente camp». La questione non è però così semplice, poiché Core prosegue sostenendo che «Le-onardo è ciò che potrei definire seriamente camp, distinguendolo dallo high camp, che per tradizione significa una frivolezza scatenata». Sembra voler individuare questa versione di camp nella rappresentazione ‘ermafrodita’ del San Giovanni Battista e della Vergine con bambino e Sant’Anna, da cui evince che il pittore «ovviamente, la maternità la sentiva dall’interno». Altro però non è dato sapere.
Tali conclusioni sono strane quanto le inevitabili omissioni. Proprio non riesco a capire perché né Booth né Core abbiano tenuto conto di Giulio Romano, per citare uno dei miei esempi preferiti. (Sto pensando al connubio di erotismo e grottesco negli affreschi di Pa-lazzo Té a Mantova, al finto rustico della sua architettura, alla scena della disfatta nella Sala dei Giganti…) Ma ognuno di noi ha le proprie preferenze, e come trovare una definizione che le includa tutte? Il problema si lega in parte al fatto che chi usa camp come termine critico si concede di indulgere nella stessa frivolezza che caratterizza il suo oggetto di studio. Riluttanti a definire in modo inequivocabile la propria parola chiave, lasciamo che la parola camp significhi qualsiasi cosa si desideri; e il significato non è mai lo stesso. A volte si manifesta nelle intenzioni dell’artista; a volte va cercato nello sguardo del fruitore. Si trova nella vita o nell’opera. È gay oppure no. Sconfina in culture e periodi storici differenti, incurante delle nette distinzioni; forse però non bisognerebbe consentirglielo…
Susan Sontag riteneva che le considerazioni sul camp di Christopher Isherwood in Il mon-do di sera (1954) fossero «pigre». Tuttavia le sue famose Note sul ‘Camp’ (1964), a dispetto di tutta la loro perspicacia, non seguono una linearità argomentativa. (E in tal senso le ‘note’ sono caratteristiche di molti dei migliori ‘saggi’ della Sontag.) Alla stessa stregua, il testo di Core si presenta come un elenco alfabetico privo di un filo conduttore.
Nel parlare di camp, ci ritroviamo così confusi e impacciati, vaneggiamo e cadiamo in con-traddizione.
Sebbene l’intento non sia qui quello di «dissezionare una farfalla» (per usare l’espressione di Alexander Pope), è chiaro che il camp non può più essere considerato una mera farfalla, per quanto alcune delle sue manifestazioni possano essere tanto belle quanto fragili. Negli ultimi decenni un’ampia parte della cultura popolare deriva da tentativi di diffondere un’estetica camp, e assai numerose sono le opere d’arte ricondotte a tale quadro estetico: risulta perciò imprescindibile confrontarsi con questa categoria. Se la Sontag aveva ragione (e l’aveva), oltre quarant’anni fa, a identificare nel camp uno dei fattori cruciali della cultu-ra moderna, gli anni a seguire lo hanno rivelato elemento ancor più fondamentale nella cultura del postmodernismo, del consumismo e della globalizzazione. Se ne evince, a rigor di logica, che il camp trova la propria straordinaria forza nella sua ubiquità.
Forse io non sono in grado, per certi versi, di delibare una tale fonte del favoloso.
Ho sempre avuto del camp un’esperienza assai scettica e parca. Sembra che io sia molto meno propenso, rispetto ad altri gay, a dire di una qualsiasi cosa, «Oh, è talmente camp!». Ma la pervasività del camp è terribilmente persuasiva. Una volta che si sia analizzato un qualsiasi artefatto, o una performance, ai molteplici livelli d’ironia che scaturiscono dalle molte possibili fonti che vi sono implicate (a partire da produttore e consumatore), persino una totale assenza di ironia, persino l’innocenza più primordiale può essere accolta con maliziosa sagacia da un pubblico assetato di camp. Qual è quell’elemento così raffinato da rimanere immune al processo alchemico che, nel momento esatto in cui si osa dire che una tal cosa non è camp, trasforma quella stessa cosa in camp - o se non altro, che stranamente estende la nostra definizione di camp così da costringerci a comprenderla? Com’è possi-bile escludere qualcosa da questo pantheon dello splendore equivoco, che sembra espandersi con lo stesso vigore dell’universo dopo il Big Bang? Non riesco a non pensare a un medico che una volta mi rimproverò, all’epoca gloriosa della mia promiscuità, con un severo motto: «Non esiste nulla che non sia venereo!». Quando penso all’argomento in que-stione, sono indotto a un analogo estremismo: forse non esiste nulla che non sia camp.
Una tale affermazione merita di essere messa alla prova. Se dovessi citare un artista che non è camp, o che non lo è stato mai, mi viene subito in mente Beethoven. Ma poi mi sovviene la Fantasia Corale (op. 80), che fa sfoggio di una gamma di virtuosismi inconciliabili, utilizzando - in venti minuti di consapevole arguzia - strane combinazioni di forze e convenzioni. Se non Beethoven, allora chi? Rembrandt? Confesso di essere ancora alla ricerca del camp in Rembrandt, ma temo proprio che salterà fuori, prima o poi. Fra i modernisti sono tentato di fare il nome di Kandinskij, fino a quando non faccio mente locale alle Baga-telle che dipinse a Stoccolma verso la fine del 1915. E così la ricerca continua. Ma se non un’intera produzione artistica, devono pur esserci singoli lavori di cui si possa affermare con assoluta autorità: qui non c’è traccia di camp. Alla ricerca di tesori così peculiari, mi rivolgo inevitabilmente a esempi di straordinario contegno: il Beato Angelico, Antonello da Messina, la sesta sinfonia di Jean Sibelius, le storie di Borges…
Tuttavia, poiché il contegno tende all’austerità e diviene materia di compiacimento e orgoglio, può ben produrre eccessi e stravaganze. (Non ci meraviglia che l’Inquisizione spagnola sia passata senza difficoltà nei raccapriccianti orrori del romanzo gotico inglese. E non ci meraviglia nemmeno che gli affascinanti malvagi del gotico, in gran parte, siano o spagnoli o italiani.) Il punto è che non basta escludere l’ornamento, l’elaborazione e la decorazione per escludere il camp, men che meno quando uno stile asciutto risulta in sé straordinariamente espansivo. Si pensi alle posizioni ostentatamente dichiarative del minimalismo: John Cage, Carl Andre, gli ultimi lavori di Samuel Beckett…
L’accenno all’Inquisizione ci ricorda - così come molti impulsi contraddittori dell’Islam (per esempio: fare un attentato suicida per godersi le vergini in Paradiso) - che lusso e au-sterità spesso si intrecciano, e quando ciò avviene, l’esito è carico di camp. In Donatello, per esempio, è la medesima sensibilità a dare origine alla lugubre anoressia di Maria Maddalena e all’assurdo copricapo del David nudo. E tuttavia, non è proprio in questa capacità di conciliare e rappresentare visioni del modo diametralmente opposte - l’Umanesimo e la Cristianità - che si trova il fulcro del Rinascimento? Non è questa potenziale spaccatura il fattore più promettente per la produzione di camp? È quanto senza dubbio accade nel Barocco, quando questo inizia a produrre le proprie storie di santità.
Se mi fosse chiesto d’indicare le apoteosi di camp italiano, credo infatti che dovrei assolutamente includere l’Estasi di Santa Teresa nella Cappella Cornaro a Roma. Non solo per l’evidente allusione sessuale (fin troppo facile e banale oggi associare l’estasi religiosa a un generoso orgasmo femminile), sebbene, lo ammetto, questa non sia del tutto irrilevante: è pure una questione di forma e materiali. Nella sua Ars Poetica Orazio sosteneva che i poeti dovrebbero astenersi dal prendersi certe libertà - «al punto d’accoppiare una serpe ed un uccello, la pecora e la tigre, e così via» - ma questo è proprio quanto tende a fare l’artista camp. L’ambientazione della Santa Teresa è piena di giustapposizioni incongrue nel suo compendio di materiali e stili (legno, stucco, marmo bianco e colorato, architettura, pittu-ra, luce…) e nel suo uso di materiali impropri (nuvole di pietra, luce di legno dorato). Committenti e mecenati dello scultore fanno da astanti nei loro palchetti laterali, quali voyeur di un momento privato reso spettacolarmente pubblico. L’opera richiede un accompagnamento musicale - non importa che si tratti di Bellini o di Donna Summer - anche solo per incrementare il novero dei sensi che fanno i conti con la sua impudenza. (Ben-ché gran parte della sensazione di teatralità che ci suscita dipenda, anacronisticamente, dalla storia del teatro successivo, possiamo confortarci ricordando che lo stesso Bernini era anche scenografo teatrale.) Teresa è chiaramente una peccatrice en travesti da santa: quella scultura è un’interpretazione del piacere spirituale da parte di una diva palpabilmente fisica, ed esibizionista.
Detto ciò, comunque, la scultura - anche quella di Bernini, anche se mossa da effetti di luce o dall’acqua che scorre, come nella fontane di Piazza Navona - mi pare un’arte troppo statica per rappresentare il camp italiano. A dispetto della grandezza dei maestri del mar-mo e del bronzo, può darsi che i migliori esempi di camp giungano dall’Italia. L’industria della moda milanese fa qui la sua parte - e chi sa dirci perché,
tra tutti e due, Mark Booth e Philip Core sono stati in grado di nominare, tra gli stilisti italiani, solo Armani ed Elsa Schiaparelli? - al pari dell’industria cinematografica di Cinecittà; e, certo, dell’opera. Ma strano a dirsi, se devo evocare le mie immagini predilette di camp italiano, mi vengono in mente due scene che hanno scrittori per protagonisti: Ga-briele D’Annunzio al Vittoriale, che per curare Tamara de Lempicka, febbricitante dopo una gita in aereo, la spennella nuda per giorni con il membro turgido; e Curzio Malaparte in esilio a Lipari per aver denigrato i gusti del Duce in fatto di cravatte. (Nell’ultima scena, mi chiedo, quale dei due contendenti è più camp?). Ma il camp italiano è ben più che una serie di individui eccellenti. Intere città sono camp, a partire dalla stessa Roma, con il suo sgargiante palinsesto di classicismo, cattolicesimo e fascismo. Vi sono poi i caratteristici piccoli dettagli della quotidianità - un funerale che si ferma al semaforo a Venezia, il vigile che canta Verdi a Napoli - oppure alcuni paesaggi urbani: l’Italia presenta infatti alcune delle più belle disposizioni al mondo dello spazio pubblico, sia esterno sia interno. Far quattro passi alla volta di un ristorante in Galleria Vittorio Emanuele dopo una serata alla Scala (a vedere la Norma, ad esempio), andare ‘a caccia’ sulla piazza per poi fare una capatina nel Duomo a pentirsi un poco: persino la persona più insensibile, prima o poi, sarebbe toccata in questa passeggiata dalla bacchetta magica del camp. Mentre in Inghilterra una passeggiata viene intrapresa, quando proprio è necessario, in nome dell’esercizio fisico, in Italia la si fa per amor di spettacolo. Walt Whitman colse qualcosa di questo spirito nella Manhattan di metà Ottocento, così come Baudelaire fece a Parigi. Paragonato al protestantesimo dei paesi del Nord, ovviamente, il cattolicesimo meridionale è intrinsecamente, in-correggibilmente camp. Ronald Firbank, quello spaurito Orlando curioso dell’effeminatezza ilare, lo sapeva bene e si beava nelle chiese di Roma, mentre a Londra si doveva accontentare del Café Royal. Gli omosessuali del Nord protestante sono da sempre attratti dall’atmosfera tutta ‘scampanii e profumi’ del cattolicesimo romano - ovvero dalla sua ritualità avvolta d’incenso, dall’abbigliamento teatrale e dall’allestimento roboante del-le sue chiese - così come dal culto mariano e dall’adorazione della figura materna in gene-rale. In Inghilterra, cattolicesimo romano e camp si sono accompagnati non solo nei ro-manzi di Firbank, ma anche nelle opere ben più note che essi hanno influenzato: la commedia sconfinante in nostalgico zelo di Evelyn Waugh (specialmente in Ritorno a Bride-shead, il cui omoerotismo pastorale cede il passo a un cerimonioso, eterosessuale cattolicesimo romano che si rivela ancor più camp, e non di poco); il cattolicesimo scettico di Gra-ham Greene; Muriel Spark e i suoi rebus postmoderni sul Libero Arbitrio garantito dall’Onnipotente, che di divinità o autore si tratti…
Ogni versione sovverte e converte quelle da cui trae origine.
Il locus classicus del camp mi pare si situi lungo la precaria faglia tra versioni così discrepanti di un tema e una pratica così comuni. Un artista capovolge l’opera di un altro, come accade a Palazzo Chiericati del Palladio a Vicenza: già di per sé un’inversione delle conven-zioni proprie alle corti del palazzo romano, viene ulteriormente complicata da Inigo Jones nella Queen’s House a Greenwich. Qualcosa di analogo, sebbene meno elegante, accade con la scultrice britannica Rachel Whiteread, che realizza la sua House (1993) facendo un calco in cemento di un ordinario edificio vittoriano a Londra.
Non è semplicemente una questione di intertestualità, ma di interazione tra immaginari distinti. L’effetto è ancora più sconvolgente quando si infrangono i confini fra epoche e culture.
Simili mutamenti hanno luogo nella storia intertestuale di Der Tod in Venedig (1913), lugubre racconto di un estetismo casto e raffinato custodito nel corpo di un quattordicenne. Il Tadzio di Thomas Mann è esile e malaticcio; la sua vulnerabilità lo rende vittima dei compagni, gli stessi peraltro a rincuorarlo nei momenti di sconforto. Nella versione più carnale di Luchino Visconti, Morte a Venezia (1971), per contrasto, l’adolescente assume i tratti languidi e formosi di Björn Andrésen, avviluppati dalla voluttuosa malinconia dell’Adagietto di Mahler e offuscati solamente dall’opulenza di Silvana Mangano. Lo splendore barocco del film è valorizzato dal modo in cui Visconti rende irrequieta la macchina da presa ogniqualvolta si trovi nelle vicinanze di un ragazzo, un abito o uno specchio. L’eloquente verbosità del romanzo si trasforma insomma nella seduzione visiva di un lus-sureggiante Liebestod. Tadzio diventerà poi aitante pentatleta nell’opera di Benjamin Britten, Death in Venice (1973). Nei «Giochi di Apollo» che chiudono il primo atto, danzati sulle note esotiche di un gamelan in versione pastiche, supera sistematicamente gli amici in ogni competizione: corsa, salto in lungo, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Non viene fornita spiegazione alcuna a questa superiorità, che si pone in netto contrasto sia con la scena che precede (in cui Tadzio è colpito e atterrato dal compagno più robusto, Jaschiu, e deve essere portato a braccia dalla madre che lo consolerà) sia con la scena finale dell’opera (in cui Aschenbach morente guarda Jaschiu premere il viso di Tadzio nella sabbia). Ovviamente queste attività atletiche non sono vere competizioni, giacché le coreografie di Frederick Ashton non lasciano nulla al caso: il più piccolo movimento è studiato e provato più volte, in modo tale da garantire l’assoluta precisione della performance. In modo cruciale, diverse forme di omosessualità entrano così in gioco in questa sequenza di testi: la paterna pedofilia post-freudiana di Mann; quella fraterna, postkinseyana, di Brit-ten; l’omosessualità di gran lunga più ostentata, ancorché opposta al liberazionismo gay, di Visconti e Ashton, che dedicano attenzione all’elemento virile più che a quello puerile… Riunite nel dare forma a differenti versioni del medesimo racconto, le loro sensibilità inconciliabili - lungi dal prendere le mosse da un’unitaria Weltanschauung ‘gay’ - entrano talmente in attrito e in contraddizione l’una con l’altra da riuscire a dar vita a un agglome-rato di ‘morti-a-Venezia’ nel quale non è dato identificare una versione definitiva, poiché ognuna si rivela produttivamente densa di difetti e incongruenze. Ne scaturisce in sostanza un’innata instabilità che mi piacerebbe definire camp.
C’è stato un momento in cui ho preso in considerazione Dante quale candidato al ruolo di artista non-camp, ma è un’ipotesi subito svanita. La forza della trilogia del poeta americano James Merrill, The Changing Light at Sandover (1976, 1978, 1980), deriva in larga parte dalla sua deliberata minaccia di banalizzare la struttura della Divina Commedia pur man-tenendone intatta la profondità tematica. Il fatto che Merrill e il suo compagno David Ja-ckson visitino il regno dell’aldilà solo per procura - con una tavoletta per sedute spiritiche e l’aiuto di uno spirito guida - conferisce ai loro dialoghi con i defunti un’intimità domestica che, pur aprendo un conflitto con le nozioni convenzionali di grandiosità escatologica e sminuendo la solennità a cui Omero, Milton, Blake e lo stesso Dante ci hanno abituato, riesce a conservare intatta la serietà delle tematiche. Tale pratica appare del resto già in parte nel modo in cui Dante sviluppò a fini cristiani la topica pagana della discesa agli inferi. Non vi è forse, dopotutto, qualche cosa di ineffabilmente camp nelle pettegole beghe della Divina Commedia, elevate dal virtuosismo di Dante (nonché dalla sua fede) quasi al livello di una teologia? E che dire poi di una celebre faccenda di dettaglio, l’esclamazione di Brunetto Latini «Qual maraviglia!» mentre prende Dante «per lo lembo» della veste (Inferno xv)? Non si ha forse un piacere particolare nel sapere che persino nei gironi infernali si può apprezzare un panno che giunge dal regno mondano?
Traduzione di Stefania Consonni e Marta Pianeti