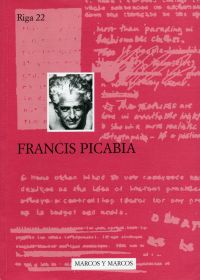Giuseppe Dierna
Picabia. Quelle sue macchine sensuali col gusto della provocazione
La Repubblica, 27 Giugno 2004
Picabia. Quelle sue macchine sensuali col gusto della provocazione
La Repubblica, 27 Giugno 2004
Francis Picabia, «campione del Dadaismo», «esploratore dell’introvabile», poeta, pittore, prosatore, e inventore di riviste altamente sperimentali, è forse il più evanescente tra gli artisti dell’avanguardia anni Dieci, il più inafferrabile, nascosto dall’ombra dei propri atteggiamenti provocatori, dietro l’ostentata ricchezza, le belle automobili, dietro intemperanze verbali quasi superiori a quelle di Salvador Dalì una decina di anni dopo. Eppure la sua figura e la sua produzione tagliano - in parallelo con Apollinaire, Tzara e Breton - il ventennio più entusiasmante di quegli entusiastici anni sperimentali, modificando (in stretta simbiosi con Marcel Duchamp, suo inseparabile compagno d’avventura) l’idea stessa del fare artistico, e proseguendo poi fino all’astrattismo quasi «informale» delle ultime opere degli anni Cinquanta, sempre lasciando tracce indelebili e stimoli che verranno raccolti e utilizzati da pittori di più diversa formazione e rango.
L’ultimo denso volume della rivista Riga, a lui dedicato sotto la direzione di Elio Grazioli (Marcos y Marcos, pagg. 451, euro 18), raccoglie strabordanti poesie (sequele di «apparente non-senso, sterzate, anzi testacoda per rovesciamenti imprevisti, pesanti ironie, leggere metafore subito abbandonate», come spiega il curatore), brevi prose, e poi robusti saggi critici e ricordi di amici (André Breton, Philippe Soupault, Georges Ribemont-Dessaignes), offrendo di quel personaggio e di quella produzione un’immagine quanto più possibile completa, e allo stesso tempo colmando una prolungata e imperdonabile disattenzione in ambito italiano.
Nato a Parigi nel 1879 da padre cubano e madre francese, dopo un promettente inizio impressionista che aveva presto attirato su di lui l’attenzione di critici e mercanti d’arte («l’impressionismo fu il cordone ombelicale che mi permise di sviluppare i polmoni»), Picabia devia improvvisamente vero un orfismo di impianto cubista, un astrattismo eretico che immediatamente gli scatena contro l’ostracismo di quegli stessi critici e mercanti che avevano stabilito il suo successo: è l’inizio di un percorso artistico ormai costantemente dominato dalla provocazione, una «sfida sontuosa al già sentito, una meravigliosa irriverenza» (come dirà di lui Breton), sempre supportata da un irresistibile gusto per lo sberleffo che lo porrà tra i fondatori del Dadaismo. Scrive nel marzo del ’20: «Matisse mi fa pensare a quegli uomini di genio che vi vendono pomate per far crescere i capelli». E il mese successivo: «Jean Cocteau ci fa sapere d’essere di estrema destra: lo vedo bene, ma a destra di cosa?».
Sarà l’impatto con New York, dove Piacabia giunge nel ’13 per assistere all’Armory Show (l’esordio americano della pittura moderna, organizzato da fotografo Alfred Stieglitz), a determinare gli esiti successivi della sua pittura: «la macchina è diventata più di una semplice aggiunta alla vita», scriverà un paio di anni più tardi, «forse ne è la vera anima». Ha inizio per lui quello stile «macchinista» cui il volume di Riga dedica giustamente grande spazio. Alla ricerca di uno stile oggettivo e impersonale (in ciò certo stimolato anche dall’amico Duchamp, che in quegli anni già lavorava al cerebralissimo Grande vetro), Picabia intraprende una divertita trascrizione del reale sotto forma meccanica.
Niente a che vedere - ovviamente - con l’asettica esaltazione futurista della macchina, della «bellezza meccanica» liberata «dal sentimentalismo e dalla lussuria», come recitava il quasi contemporaneo manifesto sull’Uomo moltiplicato. Vicine piuttosto a taluni congegni meccanici presenti nei pirotecnici romanzi di Alfred Jarry e Raymond Roussel (dal Supermaschio a Impressioni d’Africa), le macchine picabiane sembrano infatti ostentatamente dichiarare una propria enigmatica sensualità. Nascono opere come Eccola, Parata amorosa, il bambino carburatore, assemblaggi di manicotti, leve e pistoni, ma soprattutto la sfilza dei «ritratti» sulla base di «analogie funzionali»: quello di Stieglitz è una macchina fotografica dal soffietto rotto, con leva del cambio e freno a mano tirato; quello di Paul Haviland (autore peraltro di un articolo sulla macchina vista come «figlia nata senza madre», «essere femminile nato dall’uomo») è una lampada da tavolo di foggia moderna con sotto la scritta: «la poesia è come lui», mentre il Ritratto di una giovane americana in stato di nudità è un elegante candela di automobile marca «For-ever», esile come una ballerina.
La critica ci impiegherà parecchio a capire quello che sta realmente accadendo: negando - come nei coevi readymade duchampiani - l’idea stessa di originalità, Picabia utilizza in quelle opere materiali direttamente copiati dalla pubblicità o da riviste scientifiche (o da rotocalchi di dubbia moralità, come avverrà per i Nudi degli anni ’40), mentre anche le scritte che farciscono quei quadri - sbrigativamente giudicate misteriose - risulteranno non diversamente stralciate pari pari dal Petit Larousse: motti celebri, frasi storiche distorte dalla nuova collocazione. E quando nel 1921 un critico denuncerà il fatto che il suo quadro Occhi caldi era stato copiato dallo schema del regolatore di velocità di una turbina d’aereo, Picabia risponderà tranquillo di non capire davvero perché ci si scandalizzi tanto per chi copia turbine d’aereo e si consideri invece normale copiare delle mele. E lui stesso, in un Manifesto dada del ’20, aveva scritto: «comprate le riproduzioni degli autografi!», pubblicando poi sulla rivista 391 una Copia di un autografo di Ingres realizzata da Francis Picabia.
È un’arte, quella di Picabia, vissuta continuamente come mistificazione alle spalle di spettatori e critici, un controcanto ironico alla cultura, alta e bassa senza differenze: non si spiegherebbero altrimenti le sue innumerevoli variazioni sulle donne spagnole dipinte da In gres, o l’abbassamento parodico di altri personaggi della sua pittura (l’Edipo che in Ingres conversa con la Sfinge diventa in Picabia una solitaria nera silhouette quasi pinocchiesca), o il riuso della grande pittura italiana - da Botticelli a Tiziano a Paolo Veronese - nei Mostri e nelle Trasparenze degli anni ’20, o ancora i pesanti interventi con colori a smalto su banali cartoline di coppie d’innamorati, ad aggravare ancora di più il kitsch originario.
Un’arte vista sempre come altissimo gioco e così ben esemplificata dal breve film Entr’acte (1924) che René Clair gira su sceneggiatura di Picabia (originariamente per intervallare il balletto Relâche, con musiche di Erik Satie), con carri funebri trainati a rotta di collo da cammelli, con morti che riacquistano vita e giocatori di scacchi sui tetti sbilenchi di Parigi: quasi una prima esibizione del neonato surrealismo, a cui lo stesso Picabia per un brevissimo periodo si accosterà per poi - come già aveva fatto anche col movimento dadaista - rapidamente allontanarsene, incessantemente a inseguire quel suo affascinante fantasma che, in una lettera a un’amica, definirà «la ragione della mia ricerca». Anche perché, come aveva scritto nel ’24 sulla rivista 291: «la sola maniera per essere seguiti è correre più veloce degli altri».
L’ultimo denso volume della rivista Riga, a lui dedicato sotto la direzione di Elio Grazioli (Marcos y Marcos, pagg. 451, euro 18), raccoglie strabordanti poesie (sequele di «apparente non-senso, sterzate, anzi testacoda per rovesciamenti imprevisti, pesanti ironie, leggere metafore subito abbandonate», come spiega il curatore), brevi prose, e poi robusti saggi critici e ricordi di amici (André Breton, Philippe Soupault, Georges Ribemont-Dessaignes), offrendo di quel personaggio e di quella produzione un’immagine quanto più possibile completa, e allo stesso tempo colmando una prolungata e imperdonabile disattenzione in ambito italiano.
Nato a Parigi nel 1879 da padre cubano e madre francese, dopo un promettente inizio impressionista che aveva presto attirato su di lui l’attenzione di critici e mercanti d’arte («l’impressionismo fu il cordone ombelicale che mi permise di sviluppare i polmoni»), Picabia devia improvvisamente vero un orfismo di impianto cubista, un astrattismo eretico che immediatamente gli scatena contro l’ostracismo di quegli stessi critici e mercanti che avevano stabilito il suo successo: è l’inizio di un percorso artistico ormai costantemente dominato dalla provocazione, una «sfida sontuosa al già sentito, una meravigliosa irriverenza» (come dirà di lui Breton), sempre supportata da un irresistibile gusto per lo sberleffo che lo porrà tra i fondatori del Dadaismo. Scrive nel marzo del ’20: «Matisse mi fa pensare a quegli uomini di genio che vi vendono pomate per far crescere i capelli». E il mese successivo: «Jean Cocteau ci fa sapere d’essere di estrema destra: lo vedo bene, ma a destra di cosa?».
Sarà l’impatto con New York, dove Piacabia giunge nel ’13 per assistere all’Armory Show (l’esordio americano della pittura moderna, organizzato da fotografo Alfred Stieglitz), a determinare gli esiti successivi della sua pittura: «la macchina è diventata più di una semplice aggiunta alla vita», scriverà un paio di anni più tardi, «forse ne è la vera anima». Ha inizio per lui quello stile «macchinista» cui il volume di Riga dedica giustamente grande spazio. Alla ricerca di uno stile oggettivo e impersonale (in ciò certo stimolato anche dall’amico Duchamp, che in quegli anni già lavorava al cerebralissimo Grande vetro), Picabia intraprende una divertita trascrizione del reale sotto forma meccanica.
Niente a che vedere - ovviamente - con l’asettica esaltazione futurista della macchina, della «bellezza meccanica» liberata «dal sentimentalismo e dalla lussuria», come recitava il quasi contemporaneo manifesto sull’Uomo moltiplicato. Vicine piuttosto a taluni congegni meccanici presenti nei pirotecnici romanzi di Alfred Jarry e Raymond Roussel (dal Supermaschio a Impressioni d’Africa), le macchine picabiane sembrano infatti ostentatamente dichiarare una propria enigmatica sensualità. Nascono opere come Eccola, Parata amorosa, il bambino carburatore, assemblaggi di manicotti, leve e pistoni, ma soprattutto la sfilza dei «ritratti» sulla base di «analogie funzionali»: quello di Stieglitz è una macchina fotografica dal soffietto rotto, con leva del cambio e freno a mano tirato; quello di Paul Haviland (autore peraltro di un articolo sulla macchina vista come «figlia nata senza madre», «essere femminile nato dall’uomo») è una lampada da tavolo di foggia moderna con sotto la scritta: «la poesia è come lui», mentre il Ritratto di una giovane americana in stato di nudità è un elegante candela di automobile marca «For-ever», esile come una ballerina.
La critica ci impiegherà parecchio a capire quello che sta realmente accadendo: negando - come nei coevi readymade duchampiani - l’idea stessa di originalità, Picabia utilizza in quelle opere materiali direttamente copiati dalla pubblicità o da riviste scientifiche (o da rotocalchi di dubbia moralità, come avverrà per i Nudi degli anni ’40), mentre anche le scritte che farciscono quei quadri - sbrigativamente giudicate misteriose - risulteranno non diversamente stralciate pari pari dal Petit Larousse: motti celebri, frasi storiche distorte dalla nuova collocazione. E quando nel 1921 un critico denuncerà il fatto che il suo quadro Occhi caldi era stato copiato dallo schema del regolatore di velocità di una turbina d’aereo, Picabia risponderà tranquillo di non capire davvero perché ci si scandalizzi tanto per chi copia turbine d’aereo e si consideri invece normale copiare delle mele. E lui stesso, in un Manifesto dada del ’20, aveva scritto: «comprate le riproduzioni degli autografi!», pubblicando poi sulla rivista 391 una Copia di un autografo di Ingres realizzata da Francis Picabia.
È un’arte, quella di Picabia, vissuta continuamente come mistificazione alle spalle di spettatori e critici, un controcanto ironico alla cultura, alta e bassa senza differenze: non si spiegherebbero altrimenti le sue innumerevoli variazioni sulle donne spagnole dipinte da In gres, o l’abbassamento parodico di altri personaggi della sua pittura (l’Edipo che in Ingres conversa con la Sfinge diventa in Picabia una solitaria nera silhouette quasi pinocchiesca), o il riuso della grande pittura italiana - da Botticelli a Tiziano a Paolo Veronese - nei Mostri e nelle Trasparenze degli anni ’20, o ancora i pesanti interventi con colori a smalto su banali cartoline di coppie d’innamorati, ad aggravare ancora di più il kitsch originario.
Un’arte vista sempre come altissimo gioco e così ben esemplificata dal breve film Entr’acte (1924) che René Clair gira su sceneggiatura di Picabia (originariamente per intervallare il balletto Relâche, con musiche di Erik Satie), con carri funebri trainati a rotta di collo da cammelli, con morti che riacquistano vita e giocatori di scacchi sui tetti sbilenchi di Parigi: quasi una prima esibizione del neonato surrealismo, a cui lo stesso Picabia per un brevissimo periodo si accosterà per poi - come già aveva fatto anche col movimento dadaista - rapidamente allontanarsene, incessantemente a inseguire quel suo affascinante fantasma che, in una lettera a un’amica, definirà «la ragione della mia ricerca». Anche perché, come aveva scritto nel ’24 sulla rivista 291: «la sola maniera per essere seguiti è correre più veloce degli altri».